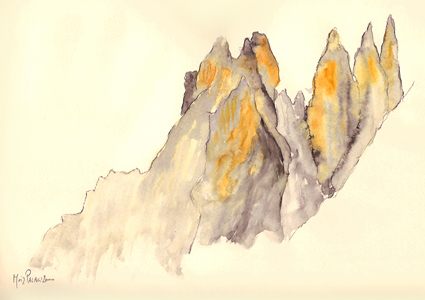
RILASSAMENTO, BEN PIÙ DI CIÒ CHE SEMBRA.
La pratica di Yoga è facilmente associata all’idea del rilassamento.
La necessità di decontrarsi è spesso la ragione che ci avvicina al tappetino. Ma il rilassamento racchiude molto più della distensione e si rivela un punto di partenza fondamentale del proprio percorso interiore.
La decontrazione può aver luogo perché ci facciamo condurre da un’altra persona oppure perché impariamo a farlo da soli. Il passaggio da una condizione all’altra è importante. A chi diamo autorità nei due casi ? Diamo autorità a chi conduce o ci assumiamo la responsabilità di dare autorevolezza a noi stessi?
Śavāsana, punto di partenza della pratica, ci lascia scoprire che è possibile affrontare il rilassamento in modo passivo o attivo, subendolo o partecipando. Nel primo caso ci si affida alla conduzione, alla voce dell’insegnante; nel secondo starà a noi capire come generare un impulso che interrompa la tensione, rimanendo in relazione con i segnali che il corpo invia durante il progredire della decontrazione.
Nel rilassamento passivo tendiamo a conferire autorità all’insegnante; nel rilassamento attivo impariamo a dare fiducia alla nostra sensibilità e capacità di cogliere i segnali che ci arrivano. Questo atteggiamento è di fondamentale importanza per affrontare le sfide successive che preparano all’osservazione meditativa.
Nei due casi sperimentiamo sensazioni diverse. In particolare, affidandoci alla nostra capacità di osservare riconosciamo che la decontrazione prende avvio da un gesto interiore attraverso il quale smettiamo di trattenere, lasciamo andare.
Un esempio? Rilassare la lingua o l’espressione facciale. Come facciamo ad alleggerire, a scaricare questi muscoli? Cosa accade?
Smettiamo di intervenire. È un mollare la presa che si propaga a cascata, da un muscolo ad un altro.
La lingua è un muscolo particolare, strettamente connesso all’attività e allo stato mentale. Mentalmente moduliamo parole e discorsi che si trasformano in micro-movimenti della lingua. Di conseguenza, la lingua non è mai a riposo. Tuttavia risponde a un nostro invito a decontrarsi e diventa il punto di partenza per rilassare i muscoli facciali e modificare il tono degli altri muscoli.
È di grandissima importanza capire come determiniamo questo cambiamento. È l’inizio di un lungo processo di comprensioni.
*** Fare amicizia con il gesto interiore del lasciar andare è solo un primo passo.
Se si crea sufficiente intimità con questo atto, abbiamo modo di riconoscere una serie di accadimenti ad esso collegati.
Ogni volta che attiviamo questo impulso necessariamente torniamo in noi, sperimentiamo l’interruzione di una forma di assopimento che silenziosamente ci accompagna. Facciamo un atto di presenza, ci riportiamo a noi stessi in quel momento, in quella circostanza. Lasciar andare chiede la nostra presenza: nessuno può lasciar andare per noi.
Possiamo poi riconoscere che il gesto interiore con cui lasciamo andare è libero da premesse, è senza condizioni. Lasciamo andare e basta. Lasciamo andare e osserviamo cosa accade, non c’è anticipazione.
Non rilassiamo la lingua per ottenere un risultato. Se c’è uno scopo, c’è anche un’aspettativa e quindi una tensione.
Poi notiamo che il lasciar andare non è legato a un tempo predeterminato. Lasciamo andare e l’effetto si attiva. Ma non sappiamo se la decontrazione sarà immediata o se si produrrà gradualmente. Nel lasciar andare non ci prefiggiamo una risposta in un tempo desiderato.
Il cambiamento può richiedere tempo. Le risposte iniziali coinvolgono il corpo in modo superficiale, ma se sappiamo aspettare continuando a lasciar agire l’impulso, la decontrazione si approfondisce. E noi scopriamo di saper riconoscere le sensazioni che la raccontano.
Con l’esperienza, possiamo osservare che il nostro lasciare la presa non è orientato. Noi lasciamo andare senza direzione. Semplicemente sospendiamo l’interferenza, facciamo un passo indietro.
Nella sua essenza, fare un passo indietro è senza scopo. Quindi non c’è nemmeno una direzione. E questo si rivela riposante per tutto l’organismo.
COSA RIPOSA NELLA PRATICA ?
Ciò che si scopre riposante durante la pratica è la capacità di convergere verso il momento presente.
Della nostra mente noi esperiamo soprattutto l’agitazione.
Poco o nulla sappiamo di quando è calma, riposata, trasparente: la conosciamo nel quadro dell’ordinario turbinio che caratterizza la sua attività.
Non sospettiamo che il modello percettivo e mentale al quale siamo abituati non esaurisce il potenziale di apprendimento a nostra disposizione.
È solo un particolare modo di recepire e organizzare i segnali che riceviamo dalla realtà della quale siamo parte.
Il rilassamento è un processo durante il quale facciamo spazio dentro di noi: non c’è nessuna forma particolare da assumere e nessun obiettivo da realizzare.
Ciò che avviene è un succedersi di momenti di abbandono che non sono guidati verso una direzione precisa. È il sistema corporeo nel suo insieme che passa a uno stato più aperto, meno colonizzato da idee e premesse emotive che influenzano l’intero organismo.
Quando riusciamo a capire come mollare la presa, il corpo sembra disporsi in una condizione più essenziale: è come sprofondare gradualmente in uno stato pacificato dove non è necessario attivare alcuna difesa.
L’esperienza di trovare spazio si palesa in noi per livelli successivi.
Vi concorrono almeno tre condizioni: la capacità di esserci, di essere in sé; la facoltà di essere in relazione con i messaggi che via via il nostro corpo e i nostri muscoli ci inviano; la pazienza di aspettare, non avere fretta di approdare a una conclusione ma restare in ascolto del progressivo alleggerimento in atto.
*** Essere in sé è lo stato che interrompe l’abitudine, il reiterarsi automatico di modelli e immagini attinti dalla memoria, da esperienze passate. È la condizione indispensabile per stabilire una relazione, un contatto diretto con i segnali che provengono dal corpo e dalla mente.
Aspettare consente di non porre anticipatamente un limite a quanto è possibile percepire nella relazione con il corpo e i suoi contenuti mentali.
Ci si rende presto conto che il rilassamento non può essere ottenuto attraverso uno sforzo volitivo e che ha livelli differenti.
Spesso chiediamo al nostro corpo o a sue parti di rilassarsi, ma abbiamo una visione confusa, approssimata di che cosa sia contratto e di come la tensione si manifesti.
Ne segue che la trasmissione dei messaggi nervosi che dovrebbero produrre la decontrazione risulta inefficace. In genere sperimentiamo una decontrazione di breve durata che non arriva a toccare il terreno da cui generano le nostre ordinarie inquietudini.
Ciò che apprendiamo durante il rilassamento si rivela di insospettata utilità per la meditazione. In questa fase gettiamo i semi per una qualità di ascolto in grado di percepire senza modificare immediatamente quanto rileviamo.
Pensiamo a un uccellino che si posi vicino a noi: per poterlo osservare senza che voli via dobbiamo farci silenziosi, quasi trasparenti; anche se immobili, basterebbe solo essere in tensione per turbare il piccolo animale e farlo fuggire. Analogamente, solo nel silenzio e nella trasparenza è possibile accostare aspetti della realtà e di noi stessi che non potremmo cogliere altrimenti.
L’osservazione meditativa è di questa natura. Ci sono parti di noi che non si lasciano raggiungere se siamo in uno stato di tensione, interiormente agitati o vincolati a troppe aspettative.
Ci vuole innocenza: uno sguardo aperto, delicato, che non alteri ciò che è possibile semplicemente osservare.
Per potersi rilassare è importante comprendere la natura del rilassamento, ma è altrettanto importante saper cogliere le condizioni che consentono alle preoccupazioni di penetrarci e ai loro effetti di trovare alloggio nel nostro sistema nervoso, quasi a nostra insaputa.
È importante capire dove dirigere lo sguardo, a che cosa prestare ascolto.
Di fondamentale importanza è saper riconoscere il particolare assopimento che ci accompagna nella quotidianità, quella specie di assenza che è il terreno in cui possono attecchire le abitudini.
Un’abitudine è un atto a cui non dobbiamo più pensare e che presenta un grande vantaggio: permette di agire senza dover essere di continuo presenti a quanto facciamo. Possiamo astrarci totalmente, possiamo pensare a qualsiasi cosa mentre agiamo in modo automatico.
Ma le abitudini comportano anche dei costi.
Quando siamo presenti ai nostri atti, segnali anche delicati vengono colti e tenuti in considerazione; quando siamo in una condizione di automatismo, i segnali deboli vengono trascurati e prevalgono solo i più forti, capaci di richiamare la nostra attenzione.
Le tensioni si formano in questo modo, un po’ alla volta, approfittando delle nostre assenze. Spalle contratte, muscoli accorciati, respiro irregolare, pensieri reiterati non appaiono né si radicano d’un sol colpo. Sono il prodotto di una trasformazione silenziosa che ha occupato via via terreno sfuggendo alla nostra attenzione.
Prendiamo in considerazione gli effetti della tensione solo quando superano la soglia oltre la quale diventano manifesti sotto forma di disagio fisico o psicologico.
*** Torniamo al rilassamento. Vale la pena osservare che, mentre le trasformazioni legate agli automatismi agiscono sotto traccia, radicandosi nel tempo, ascolto e consapevolezza hanno un effetto più rapido, agiscono dinamizzando conformazioni irrigidite, le parti di noi che hanno perso fluidità, elasticità. E ciò sembra valere sia per il nostro corpo sia per l’attività mentale. Interrompere le abitudini e i loro effetti corrisponde a tornare a essere presenti, a rientrare in noi.
Il rilassamento non è una tecnica.
Ogni volta che ci disponiamo in una posizione di rilassamento non ci imbattiamo mai nella stessa condizione corporea. Non vi è tecnica che possa sostituire l’ascolto e la relazione diretta con ciò che siamo, la percezione di com’è il nostro corpo nel momento presente.
Per quanto affaticati, possiamo scoprire come mantenerci presenti durante il rilassamento, come le risposte del corpo e della mente non siano le stesse se adottiamo una tecnica oppure se impariamo a lasciar agire l’ascolto.
Il rilassamento prende avvio da un gesto interiore, come allentare la tensione che mantiene stretto un pugno e fa aprire la mano. È un lasciare andare, un mollare la presa che si ripercuote a cascata passando da un muscolo a un altro.
RILASSAMENTO E RITMO
Cosa chiamiamo giusto ritmo? Una cadenza che consenta il formarsi di una relazione propizia ad accogliere informazioni e a lasciare loro il tempo per depositarsi.
Praticando si coglie che un ritmo veloce impedisce alle sensazioni di essere vedute, riconosciute e accolte. Quando ad esempio si mantiene un ritmo accelerato nel succedersi dei movimenti, si tende a fare ricorso agli schemi motori già definiti e di conseguenza alle abitudini.
Nella pratica quindi né inibizione né accelerazione. Entrambe creano una barriera.
L’accelerazione mentale influenza tutto il sistema nervoso, tocca i muscoli e il loro tono.
Quando si inizia una pratica spesso siamo preda del ritmo pressante che ci ha accompagnato durante la giornata. Le immagini, i pensieri si rincorrono in modo così rapido e incontrollabile da creare la sensazione che agiscano in modo autonomo. Anche la qualità del respiro riflette tale condizione. Gli atti respiratori divengono rapidi e superficiali.
L’urgenza ci confina entro una qualità di percezione superficiale. Abbiamo difficoltà a restare in ascolto per un tempo sufficiente a cogliere aspetti del vissuto meno fugaci, meno effimeri.
E cosa si intende con il necessario grado di decontrazione? Una condizione di trasparenza, una condizione che consenta l’emergere delle informazioni e la loro accoglienza.
La tensione opacizza. Ma anche la volizione personale fa barriera alla scoperta di nuove soluzioni, sia corporee che mentali. Tensione e volizione rendono difficile prendere in considerazione possibilità diverse da quelle che già appartengono al nostro schema.
Solo gradualmente, pazientando, arriviamo a disporre di un bagaglio di segnali più ricco, che dona al movimento una pienezza e una fluidità altrimenti impossibili.
*** L’uno e l’altro vanno colti e vissuti in modo diretto. La pratica e il corpo sono essenziali per dare un senso all’affermazione senza la mediazione delle parole. Esistono vissuti per i quali le normali descrizioni verbali si rivelano insufficienti. Il linguaggio quotidiano non li contempla e non prevede sostantivi e aggettivi loro dedicati.
Un riconoscimento rilevante è che il rilassamento non si può forzare.
Non lo si può determinare allo stesso modo in cui si determina una contrazione muscolare. È un’altra strada.
Bisogna riconoscere e capire come avviene.
Cosa accade in noi? Come la decontrazione prende avvio?
È un atto in cui ci si ricorda di se stessi, un atto di presenza.
Lasciar andare non basta. Si rischia mollezza o sopore.
È questo che sperimentiamo durante un rilassamento vivo, durante un rilassamento incondizionato?
Acconsentiamo a uno spazio, lasciando andare schemi e abitudini. Ma allo stesso tempo sperimentiamo un nocciolo forte al centro di noi stessi, qualcosa di essenziale che non scompare quando molliamo le tensioni.
Questo tornare in sé in cosa consiste?
Non è qualcosa che si fa, così come non facciamo il contrario di qualcosa quando ci rilassiamo, quando abitiamo i gesti. Né è qualcosa di descrivibile attraverso le parole.
È un’affermazione d’Essere.
SE LO SGUARDO CONVENZIONALE SI INTERROMPE…
Nella vita è difficile rendersi conto di quanto le nostre abitudini e gli schemi con cui guardiamo al mondo siano potenti e di come agiscano sul nostro modo di rapportarci alle cose. Siamo pervasi da premesse e modi automatici di collegare gli eventi che conducono a interpretarli alla luce di questa particolare prospettiva.
Nella pratica dello yoga, quando maturiamo sufficiente fiducia nel nostro ascolto, appare la possibilità di riconoscere ed entrare in contatto con una dimensione di noi stessi non più confinata nel convenzionale.
Raramente infatti vediamo gli eventi nella loro autenticità. appaiono già modificati o alterati dalle premesse che abbiamo accolto e che istantaneamente entrano in gioco colorando la nostra interpretazione e la nostra azione. Di questo si interessa il Raja Yoga: la possibilità di interrompere lo sguardo convenzionale e scoprire che l’intelligenza è sempre all’opera, ma in modi inusuali, insospettati e non immaginabili dall’attività mentale e dai suoi presupposti.
Con un po’ di pazienza ci si può rendere conto di questo stato. Gradualmente si realizza che la richiesta di silenzio comune a tutte le vie interiori non è rivolta tanto ai rumori che ci abitano quanto all’interferenza e all’aggiustamento continuo in atto nelle nostre relazioni col mondo.
È il significato più sottile dell’aforisma iniziale degli Yogasutra:
I-2 Yoga cittavritti nirodah : quando i movimenti automatici, ripetitivi della mente si sospendono, c’è la possibilità di percepire uno stato d’essere indiviso.
Yoga è uno stato in cui vi è consapevolezza dell’interdipendenza che tutto unisce, noi nel tutto. un modo in cui si è, non fondato su una percezione separativa, bensì relazionale. capace di cogliere le cose come sono, nella loro interconnessione.
Il testo segnala che il costante movimento mentale da cui siamo pervasi e che consideriamo così importante, il continuo turbinio così fondamentale nella nostra esistenza copre, cela, offusca un riconoscimento più fondamentale: il sentimento d’essere.
L’agitazione da cui siamo continuamente pervasi rende impossibile rilevare qualcosa di più sottile, continuo ed essenziale.
*** Un’altra modalità di comprensione si rivela e si attiva attraverso un ascolto diretto, un ascolto rilassato e aperto. Una ricettività non toccata dalle reazioni automatiche del cervello, sospese. ciò che viene recepito in tale stato non è subito convertito in idee e pensieri, ma è lasciato esistere nella sua forma originaria.
Questo ci fa tornare all’esperienza del rilassamento. una situazione particolarmente propizia per riconoscere come ogni minimo sforzo teso a ottenere il risultato è già un’interferenza: un’intromissione personale, volitiva, necessariamente fonte di tensione. la comprensione attraverso le sole parole non rende la ricchezza e la natura di questo vissuto, se non con grande approssimazione.
Il cambiamento interiore si rivela essere intimamente legato alla forza di quanto sperimentato nel corso della pratica.
Nella pratica l’azione non è rivolta a ottenere un risultato nel tempo, ma ad esperire una qualità immediata. Le forme, i gesti, il respiro sono veicoli attraverso i quali abbiamo modo di osservare noi stessi mentre manifestiamo con il nostro corpo la nostra condizione interiore.
Sperimentarsi mentre il sistema nervoso produce campi di ascolto che operano attraverso modalità diverse da quelle a cui siamo assuefatti.
Gli Yogasutra condensano il vissuto di una ricerca interiore penetrante e inesauribile, è questo che sta alla base degli aforismi e delle combinazioni di parole che li compongono. Un’esperienza tanto complessa e profonda ha avuto bisogno di un linguaggio criptato capace di parlare a generazioni lontanissime di praticanti che a esso fanno riferimento.
Da questa prospettiva il testo si rivela come un ponte tra vissuti: da un lato descrive le comprensioni emerse dalla tradizione; dall’altro sostiene l’esperienza dei praticanti che lo leggono nel presente. E’ perciò essenziale che il lettore del testo non si accontenti dei significati ordinari dei vocaboli, ma che provi a esplorare la relazione tra le parole e la pratica a cui esse rimandano.
La parola non è la cosa! Che cosa c’è dietro la parola?
Il senso che ognuno le attribuisce è uguale?
Oppure è personale e differente?
La presenza e l’osservazione meditativa richieste dalla pratica sono condizioni che consentono di superare il confine concettuale del linguaggio per riconoscere il vissuto a cui le parole rimandano.
Affiancando la pratica al testo degli Yogasutra, gradualmente ci si accorge che ogni affermazione è soggetta a continue mutazioni: il lettore si scopre a rivedere il senso degli aforismi alla luce dell’evoluzione dei propri vissuti.
Si può arrivare a sperimentare condizioni per cui non si trovano parole adeguate o che solo in parte possono essere descritte. In questo senso è meglio non conferire autorità solo alle parole e non accontentarsi dei significati consueti.
*** Nel corso degli anni abbiamo capito che la meditazione non è solo una condizione della mente, ma incide in modo concreto e immediato sull’organizzazione dei nostri gesti e sulla nostra postura. Di conseguenza la pratica diventa luogo di incarnazione dei propri stati, e quindi luogo di apprendimento.
I muscoli manifestano continuamente la condizione mentale, la dispersione e la presenza, le abitudini e i momenti in cui siamo liberi dagli schemi. Prima di averli sperimentati nella concretezza del corpo, noi non sappiamo veramente di cosa si tratti.
Spesso c’è discordanza fra ciò che riteniamo mentalmente e ciò che il nostro corpo racconta. Questa osservazione protegge dal raccontarsi delle storie.
Un salto di consapevolezza avviene quando si sperimenta come mente e corpo appartengono a uno stesso sistema e che sono speculari: non si può essere rilassati nel corpo e inquieti mentalmente. I due piani dialogano e si influenzano in tempo reale. Osservare come le proprie comprensioni possano incarnarsi nella pratica, diventare espressione fisica, si rivela un passaggio di fondamentale importanza.
L’evento sorprendente è che questa interazione può essere vista. È possibile vedere e riconoscere l’interazione continua fra accadimenti corporei e accadimenti mentali. E osservare che i muscoli non possono veramente decontrarsi se la decontrazione non esiste anche nella mente.
Noi siamo processi unitari e integrati. Questo riconoscimento è al fondamento del percorso indicato negli Yogasutra. Ci vuole grande pazienza e molto lavoro per averne davvero coscienza, ma evidentemente non è un punto di arrivo. È un punto di partenza.
La sfida è impostata nel primo degli Yogasutra di Patanjali: Atha yoganushasam: ora che siete pronti, che ne avete la motivazione, sarete introdotti allo Yoga.
Tutto il percorso e l’evoluzione tracciata da Patanjali conduce a intendere il termine yoga nella sua accezione di modo in cui si è, di stato.
Uno stato in cui la convinzione di essere un’entità separata, un Io distinto, lascia il posto alla consapevolezza che nella vita non esiste frammentazione. Tutto è unito ed Io esisto e mi trasformo insieme a tutte le altre cose.
Anche la parola Atha è carica di significato: adesso, a questo punto della vita, e non prima. Sottintende “ora che siete pronti, che avete la sufficiente intensità per confrontarvi con la vostra esseità”.
Nessuno può essere obbligato ad accorgersi del proprio stato d’essere. È necessaria una domanda, un interesse autentico che nasce in ognuno in modi e tempi diversi.
La premessa insita in questo sutra presuppone che il praticante abbia già l’anelito di una ricerca interiore: Qual è la natura della vita? E io come mi pongo nell’esistenza? Cos’è la realtà attorno a me? Io ne sono separato o ne faccio parte? Come mi relaziono con il mondo esterno? E con il mondo interno?
Si può praticare senza riconoscere questa domanda oppure se ne può avere coscienza, e ciò determina una differenza radicale.
…
Il senso dell’aforisma diventa: ora (che siete pronti), il vostro sentimento d’essere vi sarà rivelato.
Confrontarsi con tali interrogativi richiede una revisione del proprio modo di ascoltare e dei ritmi mentali che accompagnano l’osservazione. E una revisione delle regole che sottostanno e influenzano in modo inavvertito la relazione investigativa.
Il processo di apprendimento nel Raja Yoga conduce a non separare l’azione fisica (asana) dallo sguardo necessario a riconoscerne la natura (dhyana), senza avere l’urgenza di convertire il percepito nelle categorie della propria mente. Col procedere si intuisce la possibilità di un cambiamento di sguardo che colora l’azione e il gesto nell’asana.
Mentre la coscienza mentale sceglie, seleziona, procede per attaccamenti e avversioni, la meditazione si fonda su uno sguardo non selettivo.
Non vi è scelta o scarto di una parte per un’altra. Il particolare viene visto nella sua connessione con il resto.
Il grossolano non viene scartato per il sottile, né l’oggetto separato dal suo contesto. Senza bisogno di separare, si osserva il funzionamento del particolare e la sua relazione con l’insieme.
L’enfasi è sull’unità della vita.
A questo sguardo siamo impreparati. Dunque la funzione della pratica e delle asana è innanzitutto educativa: mettere il ricercatore in condizione di sorprendersi in uno stato di osservazione inedito, diverso da quello dominante e operante ogni giorno.
Il luogo di investigazione è l’uomo, il corpo umano. Capire come si possa osservare e agire senza bisogno di separare una parte dall’insieme a cui appartiene.
C’è una comprensione che avviene attraverso le parole e i significati che la cultura e la convenzione hanno loro attribuito.
E c’è una comprensione che ha luogo attraverso una ricettività rilassata, quando non c’è l’urgenza di convertire il percepito nelle categorie della propria mente, ma c’è la pazienza di restare in relazione con gli eventi osservati per un tempo sufficientemente lungo.
Non si percorre questa strada tutta in una volta. Si devono scoprire nuove modalità di percezione, si deve accettare di giocare su un campo che ha regole diverse da quelle adottate quotidianamente. Non si tratta di acquisire nuove cognizioni o nuovi valori, ma di sviluppare e rinforzare facoltà già esistenti dentro di noi.
Nel percorso del Raja Yoga diviene evidente che la trasformazione avviene attraverso un succedersi di piccoli riconoscimenti, da terreno consolidato a terreno consolidato dice Patanjali. Ed è resa possibile da una qualità di ascolto e di osservazione che consente di sperimentarsi al di là dei modelli ai quali ci riferiamo nel quotidiano. Sperimentando così successivi ampliamenti dello sguardo, arrivando a includere e integrare gli eventi anziché selezionarli ed escluderli.
Si scopre che nella pratica l’azione non è rivolta solo a ottenere un risultato nel tempo, ma a esprimere una qualità immediata. Si impara a stabilire una particolare relazione di attenzione: ci si lascia raggiungere e informare da segnali che riguardano noi stessi quando non siamo «in rappresentazione». Ovvero quando smettiamo di recitare come se fossimo di fronte a un pubblico, reale o immaginario.
L’idea che abbiamo di noi stessi determina delle priorità nell’organizzare le nostre azioni. Se l’idea si modifica, si modificano le priorità. Anche il nostro modo di praticare cambia e gli asana diventano un’occasione per osservare e apprendere anziché cercare una performance.
….
La tranquillità della mente da accesso a questo riconoscimento: noi continuamente riceviamo un flusso di informazioni, dall’esterno e dall’interno allo stesso tempo, e prima possibile le configuriamo in modo che siano coerenti con il nostro conosciuto e con la nostra idea di noi stessi.
Vimala Thakar ci diceva: « Quando un praticante è in grado di lasciar acquietare il movimento mentale, si rivela una ricettività incontaminata dalle funzioni automatiche del cervello. Ciò che viene ricevuto non è convertito in idee e pensieri ».
La natura e la ricchezza di questo afflusso non nasce dal pensiero, poiché lo precede. Ci troviamo nel terreno dove i pensieri e le idee prendono forma. Dunque, quando c’è interesse autentico ad apprendere non c’è ripetizione.
È tuttavia vero che la comprensione necessita passaggi successivi. Senza questo ripercorrere i vissuti non si impara nulla, non si ha accesso a ciò che si colloca oltre il confine della nostra immagine consolidata.
Per imparare ci vuole vigilanza, curiosità, intensità e rilassamento. Ci vuole la capacità di visitare consapevolmente più e più volte situazioni che ci sono sconosciute.
Ci sono sconosciute, ma non ne siamo esclusi.
Mai come in questo nostro tempo ritrovare la capacità di consapevolezza sembra importante.
Viviamo in un mondo che diviene sempre più veloce, in cui le regole, le situazioni di riferimento, i ritmi, la fasi di adattamento cambiano in modo rapidissimo. E tutto ciò determina una chiara pressione sulla mente e sulla nostra coscienza. In modo più o meno consapevole, percepiamo tutti questa pressione e la necessità ad essa connessa di modificare qualcosa nella qualità della nostra esistenza.
Alla velocità possiamo rispondere, come quasi sempre avviene, facendo ricorso a schemi di comportamento e di pensiero, ad abitudini, a situazioni in cui non è necessario riflettere, dove la risposta è rapida e automatica. Oppure possiamo rispondere con la nostra capacità di presenza, riscoprendo il ruolo che la consapevolezza ha su di noi, sulla nostra struttura psicofisica, sulla nostre azioni.
La differenza fra le due soluzioni sta in un diverso grado di libertà interiore. Quando reagiamo automaticamente, in qualche modo siamo addormentati. Di conseguenza gli eventi hanno un grande potere su di noi e difficilmente siamo soddisfatti della nostra esistenza.
La chiave che consente di scendere dalla “giostra” è un atto di presenza a se stessi: aprire gli occhi, rendersi conto. Uno spazio di consapevolezza che cambia le risposte, che ci accorda una nuova possibilità.
Ovviamente questa condizione va scoperta, sperimentata, esplorata. Occorre farci amicizia. Ma fondamentalmente è semplice, è in tutti noi. E’ solo questa l’essenza della pratica di yoga.
Amici, andando al nocciolo della questione – la nostra vita nella quotidianità – mi sembra che un modo innovativo di vivere, dal momento in cui ci svegliamo la mattina a quello in cui ci addormentiamo la sera, sia quello di porre cura in tutto ciò che facciamo: dal lavarci i denti al vestirci, al cucinare il pranzo, al parlare con qualcuno, al modo in cui ci muoviamo.
L’invito che vi rivolgo è quello di essere pienamente attenti a tutto ciò che vi si presenta nel corso della giornata, di ogni giorno, senza fare niente per abitudine. Infatti, l’agire quasi automaticamente si accompagna con la disattenzione e non richiede l’intervento diretto dell’intelligenza.
Anziché comportarsi in modo così passivo, poniamo a noi stessi questa domanda: «Riesco a essere attento, del tutto presente, qualunque cosa io faccia?».
Nessun momento è più importante di un altro; i momenti – tutti – appartengono a quella che viene chiamata ‘eternità condensata’: ciascuno è sacro.
Dunque, «riesco a essere attento a ogni movimento e in ogni rapporto? Riesco a essere interamente presente qualunque cosa io faccia, in modo tale da vivere pienamente?».
Nel cammino verso la non sofferenza tutte le tradizioni dicono che la pace della mente, la stabilità della mente sono indispensabili per percepire la Sorgente che è in noi, la nostra Capacità di Vita.
Il sistema mentale è lo strumento più sottile di cui disponiamo. Esso permette la relazione tra Drashtar , Ciò che in noi percepisce, ed il mondo esteriore. Ma non è lo strumento adatto a cogliere appieno Drashtar, perché la sua natura non lo consente. Ma anche se non possiamo spiegare né pensare questa Fonte, possiamo “riconoscerla” e vivere a partire da essa.
Per mezzo dello Yoga possiamo affrancare il nostro sistema mentale dai suoi schemi e pacificarlo, creando le condizioni affinché si armonizzi col ritmo cosmico, lento e naturale, del corpo. Allora, in modo spontaneo, dopo una giusta pratica, possiamo vivere l’esperienza della pace della mente e accedere così, senza parole, in modo quasi inatteso, a questa pienezza, a questa trasformazione. Questa esperienza depone in noi un seme che crescerà da sé.
La nostra abilità, la nostra arte starà nel permettere a questo seme di germogliare secondo i suoi tempi: troppa pratica potrebbe soffocarlo, troppo poca farlo seccare. Questa esperienza ci trasforma e da accesso alla Vita, facilitando la relazione tra noi e gli altri, relazione che non può essere affidata esclusivamente al nostro intelletto critico e ragionatore. La Vita è la gioia di essere completamente disponibili a tutto ciò che ci circonda. La relazione non può avvenire che grazie alla Sorgente che è in noi, “dalla mia anima alla tua ” dice lo Zen.
La vita è movimento. Tutto evolve senza sosta. Non giustapposizione d’avvenimenti ma flusso, evoluzione che gli avvenimenti accompagnano. E’ la vastità del cielo, non le nuvole che vi transitano. Ogni avvenimento è passeggero: muore ad ogni istante e subito rinasce sotto altra forma. Non è mai l’effetto di una sola ma di più cause. E a sua volta diventa causa: è l’eterno movimento dell’Energia. Qualunque sia il nostro problema, non è in nostro potere di arrestarlo. Non siamo testimoni esterni che giudicano o comparano. Malgrado ciò che il nostro ego ci suggerisce, noi non siamo separati dal flusso della Vita.
Sono le nostre paure, le nostre distorsioni a creare la sofferenza.
Vivere a partire dalla nostra Fonte interiore ci pone in uno stato di continua disponibilità al cambiamento. Quando gli automatismi ed i condizionamenti del sistema mentale ci abbandonano, in quel momento, siamo liberi: viviamo nel presente. Senza sforzo da parte della nostra volontà accettiamo il rinnovamento. L’ego ci lascia. Viviamo pienamente l’avvenimento senza giudicarlo: lo accettiamo.
Inscritti nel presente, siamo la Vita nel momento stesso in cui si svolge, nè prima nè dopo.
Patanjali: “La vita si situa nell’istante presente. Il nostro rapporto col passato (memoria) e con l’avvenire (proiezione mentale) è di altra natura.”
… quando, attraverso l’osservazione, la mente stessa diviene consapevole di sé, allora le risulta più facile governare la sua attività, regolando l’ordinario flusso caotico e incontrollato dei pensieri fino a sospenderlo. In definitiva, è il sistema (nervoso) che educa se stesso intervenendo a livello biochimico, fisiologico, psicologico…
È un evento straordinario quando si riesce a sospendere il flusso dei pensieri, quando non transita per la mente alcun pensiero, quando non si accende alcuna emozione e ci si trova in una condizione di riposo e di rilassamento totale, senza divisione o alterazione: uno stato di unità esente da turbamenti, libero da tensioni.
Sapete, essere in tale condizione ‒ priva di contenuti mentali ‒ comporta il sospendersi del tempo, della nozione ordinaria del tempo che si lega all’attività, al fare…
Quando la mente si dispone naturalmente verso questo stato di quiete, allora può immergersi in quella che chiamiamo ʻla vacuità del silenzioʼ.
La vacuità non è però assenza, nullità: essa è pregna di quella energia non condizionata dalla specie umana.
L’uomo si è trastullato con il gioco futile di condizionare l’energia vitale. Ora, invece, è sfidato a esplorare e a vivere in una dimensione non condizionata da se stesso: è invitato a raggiungere la pienezza dell’essere.
Gli uomini vivono sapendo che la morte è al termine della strada e che non vi è alcun cammino che possa fuggire questa conclusione. Perciò il procedere dovrà compiersi nel senso contrario, e dirigersi dalla morte verso la Vita. Una Vita guadagnata durante l’esistenza, risultato di una lunga ricerca e duri combattimenti. Il passaggio per il crogiolo è necessario. E’ qualcosa di comparabile all’operazione condotta dagli alchimisti. Il risveglio dell’oro, che ogni essere cela avvolto in un magma spesso inestricabile, è liberatorio e di conseguenza apre a un’uscita dai diversi condizionamenti che tengono prigionieri il corpi, l’anima, lo spirito.
Di buon grado le tradizioni parlano della nozione di esilio dalla patria celeste. L’esistenza è dunque considerata come una via di ritorno a uno stato originale, il quale implica una costante decreazione. Perciò l’uomo è esiliato da se stesso; è assente da sé, gli è necessario apprendere a ritrovarsi nel fondo più abissale del suo essere. Quando si rivela la conoscenza del cuore, incantato l’uomo abita (sosta) nel riposo. A lungo la sua nostalgia per l’amore e per la luce resta velata, è necessario che egli apprenda a conoscersi, a sapere ascoltare la chiamata, all’interno di se stesso, del grano di senape, di riso di mostarda che vuole germogliare, crescere e che reclama il suo nutrimento come un bambino affamato piange per significare la sua presenza alla mamma che momentaneamente lo scorda.
L’uomo è propenso a credersi ‘vivente’ nella misura in cui ragiona, parla, scrive, dialoga possiede e si proietta all’esterno; ha sete di acquisire, e nell’affermarsi non cessa di paragonarsi agli altri. Talvolta soffre della sua instabilità, più sovente si accomoda al suo interno rifiutando negli altri quel gioco di alternanze che accorda a se stesso.
Un’esistenza di questo genere è larvale e dunque terribilmente limitata. Le mutazioni, fonte di metamorfosi, si mettono in atto quando l’uomo interiore nasce e scopre in se stesso la sua dimensione profonda; le energie trasfiguratrici che tiene nella sua segretezza sgorgano e divengono operanti. Nuovi sensi si formano al pari di organi sottili. Più che di acquisizioni si tratta di ‘spogliamenti’ successivi, sempre più ampi e incisivi. Il termine ‘spogliamento’ ha qui il senso di pulire, dissodare. Implica liberare una struttura iniziale; la quale è più luminosa che opaca, più armoniosa che confusa. Quando l’uomo ritrova la sua unità primordiale, trova equilibrio nel suo corpo, nella sua anima e nel suo spirito. E’ finalmente affrancato dai morsi degli avvenimenti esterni che lo rendevano prima d’ora comparabile a un relitto trascinato e costantemente sballottato dalle onde. Da qui la spossatezza del suo corpo e del suo spirito, i dubbi, le angosce, le malattie.
Strane queste giornate segnate da una solitudine imposta.
Solitudine che può tradursi in passività, in tempo subito, ma anche in un’opportunità, in un’occasione per guardare meglio in noi stessi, i nostri percorsi interiori.
Le circostanze particolari che stiamo vivendo ci hanno confinati in una sorta di sospensione che presenta non poche similitudini con lo spazio che si determina quando pratichiamo, un intervallo che ci consente di sottrarci al consueto.
Così come nella nostra pratica siamo invitati a scoprire che i gesti possono organizzarsi lungo tracciati diversi da quelli a noi noti, anche in questo spazio imposto, illimitato e confinato allo stesso tempo, possiamo scoprire che in grande misura le azioni che ci sono abituali possono trovare una sospensione.
In entrambi i casi, le nostre premesse sono inoperanti. Abbiamo l’opportunità di sperimentare noi stessi al di là dei modelli ai quali ci riferiamo normalmente. Una delle cose più difficili per noi è prendere le distanze dal proprio “pensato”. Esiste quello che pensiamo, ma esiste anche quello “che non siamo in grado di pensare”: noi stessi in un modo diverso.
L’idea che abbiamo di noi stessi è il paradigma di riferimento, l’immagine che plasma il nostro corpo, la nostra postura, il modo in cui organizziamo i nostri gesti e anche, oltre a questo, l’interazione con gli altri. La scoperta che la pratica ci regala avviene quando ci sorprendiamo essere diversi, come se postura e gestualità appartenessero a qualcun altro. Com’è possibile questo? Cosa si è interrotto in noi? E se qualcosa si è interrotto, cos’altro è rimasto attivo?
La finezza, la difficoltà della pratica suggerita da Patanjali sta nell’offrire la possibilità di nuovi scenari, nel modo in cui interpretare le nostre percezioni. È un “fuori quadro” della nostra coscienza, che non possiamo anticipare o prefigurare: non ne sappiamo nulla fino a quando non vi siamo immersi.
E ora, a causa di un invisibile virus, su tutto il territorio nazionale ci è imposto di arrestare tutto, di “rimanere in casa”! Di sospendere tutte, o quasi, le attività, le azioni che definivano la nostra quotidianità, il nostro modo di essere. In particolare, rinunciare a quel ritmo incalzante di atti e di pensieri, di parole e reazioni che in quest’epoca ci definisce, ci identifica. E se questo non è certo facile, può tuttavia rivelarsi interessante.
Sentirsi vivi in altri modi, prendere le distanze dal “pensiero” a cui attingiamo, interrogare il nostro essere vivi “al di fuori” dei soliti schemi.
Questo “al di fuori” sembra essere una condizione propizia per riconoscere che esiste un altrove della coscienza.
Quando Patanjali all’inizio degli Yoga Sutra afferma:
Yoga chittavritti nirodah (I-2) [Essere uno – un altrove della coscienza –diventa possibile quando l’attività reattiva della mente si sospende], sembra invitare a farsi da parte, a liberare uno spazio per una parte di noi impensata.
Questo è un punto di partenza interessante per una riflessione sulla nostra pratica, una rivisitazione delle ragioni che stanno alla base del nostro yoga.
Renata e Moiz
… Cambiare ottica non è facile, né immediato.
Richiede tempo e motivazione…
Nello stato di osservazione si percepisce,
ma non si fa nulla.
Non si è attivi, ma nemmeno inattivi.
Non è sopore, ma non è neppure reazione. (Vimala Thakar)
Non abbiamo modo di sapere in anticipo a cosa corrisponda in realtà il cambiamento indicato negli Yogasutra. Potremo documentarci fino a divenire degli eruditi sull’argomento, seguire vari seminari di approfondimento, ma finiremo per scoprire che il nostro cervello organizza i dati in base a esperienze consolidate. È come cercare di conoscere il sapore di un frutto sconosciuto attraverso le parole di amici che ce lo descrivono: solo assaggiandolo noi stessi sapremo davvero di che sapore si tratta. E sarà sicuramente diverso da ogni idea che ce ne saremo fatti.
Che cosa dunque apprendiamo? Che esiste una differenza fra conoscenza e comprensione. E che la mente privilegia la prima. La conoscenza è legata alle parole, quindi ai significati collettivi e personali che alle parole sono associati.
La vera difficoltà nella pratica è prendere le distanze dal proprio pensato, sospendere le idee sedimentate in noi circa il nostro corpo e il modo in cui esso può esprimersi. Scoprire che una forma che assumiamo non si riduce solo al modo in cui i gesti si organizzano per realizzarla. Ma risente anche dell’idea che noi abbiamo a monte di tale forma. Solo quando sperimentiamo che, non sapendo, funzionalità ed elasticità dei nostri muscoli operano in modo diverso da quanto siamo abituati ad aspettarci, si apre di fronte a noi un campo di esplorazione imprevisto.
Ovviamente durante la pratica sappiamo quello che stiamo facendo, a quali forme diamo vita, per esempio il cobra, eppure allo stesso tempo accettiamo di non sapere come l’azione dei muscoli debba dispiegarsi a tale scopo.
Sviluppiamo con pazienza uno sguardo che non sa. Guarda ma non sa, come naturalmente facciamo quando giochiamo o quando cerchiamo di capire dove stia il guasto in qualche meccanismo. In questi frangenti sperimentiamo un silenzio spontaneo che però, quasi sempre, passa inosservato. Non viene visto.
Non viene visto perché siamo portati a prestare attenzione a forme e risultati. Dare preminenza a forme e risultati plasma il nostro pensiero e impregna il sistema nervoso. Di conseguenza siamo portati a riferirci a un soggetto che fa, a riconoscere un legame diretto fra desiderio-volontà e movimento-forma. E ciò spinge alla performance nell’azione: come sono bravo se assumo una certa postura, se ottengo un determinato effetto. Si assiste a una “teatralizzazione” delle azioni, i gesti divengono appariscenti, non spontanei, anche quando recitiamo solo per noi stessi.
Un’alternativa sta nello spostare lo sguardo allo stato delle cose, al modo in cui le cose si trasformano in noi e attorno a noi. Si comprende allora che il cambiamento ha la natura di una trasformazione silenziosa e graduale, come il germogliare di un seme.
La grande scoperta che facciamo, a determinate condizioni di ascolto e di pratica, è che la nostra condotta e l’organizzazione dei nostri gesti si dispiega da sé, la comprensione si diffonde senza un progetto intenzionale, per auto-dispiegamento e senza incontrare attrito.
Il cambiamento lo sentiamo avvenire nel rilassamento, nel modo in cui prendiamo contatto con il corpo, senza la pretesa di agire. Basta riconoscere lo stato delle cose.
Lo sentiamo nel modo in cui i nostri muscoli generano il movimento, pur nel rispetto dei limiti che ci caratterizzano. E nel modo in cui i piedi dialogano con il pavimento e trasmettono le forze di questo contatto a tutto il corpo.
Lo sentiamo nel modo in cui la nostra postura verticale accoglie la risalita del radicamento, nella particolare sensazione di plasticità che dalla nostra struttura emana.
Quante volte abbiamo ripercorso i movimenti e siamo rimasti nelle posture prima di notare un cambiamento nel nostro modo d’essere, nel nostro approccio? Sentirci liberi dall’impazienza ma anche dall’inerzia, né volontarismo né passività.
Quando si è arrivati a una simile comprensione? C’è stato un momento preciso o le informazioni si sono depositate in noi in modo delicato, silenzioso, fino a divenire percepibili ed evidenti?
Infine cominciamo a disporre di un sapore che consente di accedere al senso della metafora usata da Patanjali nel quarto capitolo degli Yogasutra (IV,3), quando dice che un nuovo piano di coscienza si determina similmente al gesto di un contadino che abbatte l’argine di un canale per permettere all’acqua di scorrere nel campo; così il dissolversi degli ostacoli è all’origine dei cambiamenti in noi.
Renata e Moiz
